| Pubblicato su: | Il Regno, anno I, fasc. 16, pp. 3-5 | ||
| (3-4-5) |
|||
| Data: | 13 marzo 1904 |
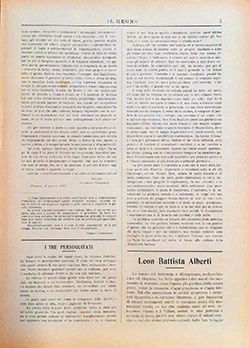
pag.3

pag.4

pag.5
3
La nostra età letteraria e dilettantesca, scribacchiatrice ed elegante, ha fatto apparirei due secoli che successero al trecento come l'epoca più gloriosa della nostra gente, come la rinascita d'ogni grandezza e d'ogni bellezza. Noi che ammiriamo le civiltà attraverso i caratteri tipografici e le cartoline illustrate, e, per impotenza, di creare monumenti nuovi ci vantiamo amici dei monumenti vecchi, — noi che amiamo assai gli eroi, attraverso Omero e il Villani, seduti in una poltrona e accanto il fuoco, perché non siamo capaci di azioni eroiche — noi che siamo piuttosto attratti dalle ben levigate
4
eleganze che fioriscon le chiese e i palazzi delle città cortigiane che dalle pietre irsute delle fortezze, abbiamo consacrato il quattrocento alla gloria della Resurrezione. Un'epoca di letterati ha magnificato un'epoca letteraria e continua ad esser fiorente la leggenda della notte medioevale.
S'è dimenticato che se qualcosa potè rinascere ch'era morto qualche altra cosa avea dovuto morire e non si curò se le cose riapparse valessero le sparite. Ma noi tutti, uomini fatti di cultura di pedanteria e di gentilezza sedentaria, abbiamo ammirato ed amato quel secolo straordinario in cui si compié il nostro disfacimento e si generò la nostra più profonda decadenza.
Infatti il Quattrocento segna il trapasso della civiltà attiva, originale, rude e forte del medioevo alla civiltà verbale, imitatrice, ipocrita e pacifica che ha dominato fino ai nostri tempi. Il Quattrocento ha visto gli uomini dei fatti cedere il passo agli uomini delle parole e il libro prender luogo della spada, il palazzetto fiorito della fortezza, il dilettantismo scettico della fede ostinata. Il tempo in cui si compievano i grandi fatti s'é trasformato in quello in cui si pregiano le grandi parole — invece di operare s'è preferito narrare ciò che gli altri avevano operato e l'arte e la letteratura da liberazioni e da sfoghi dello spirito son divenute modi sapienti per ottenere fama e potenza.
All'uomo che sapeva poco dì lettere ma era forte di corpo e austero d'animo e sapeva conquistare isole e governare città si va sostituendo a poco a poco l'umanista insinuante, che si fa macro su Cicerone, ammira le gesta dei grandi uomini chiuso fra quattro pareti, si fa storico dei fatti passati e precettore dei fatti futuri, ma non sa né può agire nel presente. A una civiltà fatta di muscoli di pietre e dì ferro ne succede una fatta di nervi, di penne e di carte e se non mancano i poeti per fare degli inni mancano gli eroi che sian veramente degni d'ispirarli.
Il dominio dell'esteriore, direbbe un filosofo, cede il campo al dominio dello interiore e i mercanti si tramutano in letterati e i guerrieri in pittori. Quello che sì usa chiamare Rinascimento potrebbe dunque apparire, per certi versi, un decadimento e un indebolimento. E a noi appare sinceramente tale e siam d'opinione che se l'Italia volesse ridarsi una vita più intensa ed energica di quella che ora mena tra le accademie del parlamento e i giocattoli delle parole, dovrebbe risolutamente finir di cacciare quelle malattie eleganti che il Rinascimento le ha messo nel sangue per sua debolezza, e risalire a più profonde e più amare sorgenti, dimenticare le lascivie ornamentali e le dilettazioni rettoriche ed astratte per mettersi a fare piuttosto che a parlare, a rifare piuttosto che ad ammirare.
Questo insegnamento potrebbe esser ricordato dal centenario di Leon Battista Alberti che ricorre quest'anno 1
1 L'A. nacque nel 1398 secondo il Manni, nel 1407 secondo lo Scipioni, nel 1414 secondo il Tiraboschi. La data del 1404, adottata anche dal Mancini, è la più comune.
se codeste solennità servissero veramente a trarre dai grandi ciò che possono darci di più prezioso, se ci facessero riflettere sulle ragioni di quella grandezza e sui moniti che ci dà la loro vita, e non fossero invece semplici occasioni d'interessata erudizione o di vanità municipali.Perché l'Alberti significa nella sua persona quel passaggio dall'età eroica e fattiva del medioevo, a quella graziosa e parolaia che venne dipoi, e segna, meglio del Petrarca o di Leonardo ai quali è fratello, quel contemperamento di concezioni di vita che doveva cessare coll'ultima degenerazione spirituale del seicento. E insomma quello che si potrebbe dire, coll'espressione dell'Emerson, l'uomo rappresentativo del Quattrocento, rappresentativo di tutto quel secolo così triste e meraviglioso in tutta le sua ambiguità o universalità. La sua vita é veramente uno specchio dei tempi.
Vedetene lo origini. Egli discende da quella gloriosa famiglia Alberta che ha dato a Firenze mercanti fortunati uomini di governo e faziosi turbolenti. Nel tempo in cui egli nasce la famiglia è bandita dalla sua città dalla parte avversaria e Leon Battista nasce a Genova, nell'esilio, ove i parenti continuano la mercatura e agognano il ritorno in patria. Egli potrebbe, seguendo i suoi maggiori, farsi mercante ed uomo di parte, conquistare ricchezze e governare gli uomini. Invece egli preferisce darsi alle lettere. Lo studio attrae il giovinetto. Egli vuol sapere di greco e di latino e leggere Platone e Virgilio piuttosto che umiliarsi a mandar drappi in Oriente o a battagliar coi signori.
Da ragazzo il padre cercò di educargli il corpo, di farne, innanzi tutto, un bello e forte giovine ed egli, raccontano, domava i cavalli selvaggi e saliva sui monti più impervii. Ma la dolcezza delle lettere lo richiamò e a Bologna, ov'egli si recò a studiar legge, si pose con tanto ardore allo studio che il suo corpo s'indebolì, le malattie lo assalirono e divenne, di giovine forte, un macilento e tremante erudito, che soffriva di mali nervosi e perdeva la memoria.
Come lui anche la razza s'infiacchiva negli studi e nei piaceri più raffinati preparando il tempo in cui, piuttosto che di ferite, si muore di paralisi.
Ma lo studio lo consolava di tutto e le lettere e la filosofia gli facevano spregiare il resto. Pericoloso contatto quello degli antichi! Quegli uomini del quattrocento, quasi barbari giunti in una città meravigliosa, si sentivan presi di riverenza in mezzo alle opere dei vecchi greci e dei vecchi latini e disperavano di poter far meglio. Per tenersi vicini alla perfezione imitavano e il loro desiderio maggiore era che i dotti scambiassero le loro carte con quelle dei maestri divini. Così quando l'Alberti, negli ozi bolognesi, rappresentò i suoi amori allegorici colla sapienza in una commedia che chiamò Philodoxeos, egli dette voce che fosse il ritrovamento di un antico poeta latino, di un Lepido comico, e godè che i letterati del tempo fossero tratti in errore.
Non c'era dunque più l'indifferenza per la gloria degli oscuri artefici che edificarono nel medio evo le grandi cattedrali e le ornarono di sì strane sculture senza cercare di lasciar memoria de' loro nomi, e neppure la sicurezza del genio nuovo il quale è sicuro della personalità e novità sua, e manda sotto il suo nome la sua creazione, ma c' era invece la cura di mettersi sotto le spoglie di un antico, sotto la protezione venerabile di quelli ch'erano ammirati allora, intendendo quasi che egli non voleva far più di loro, ma come loro.
Ora questo carattere di servilità intellettuale rispetto agli antichi lo ritrovate in quasi tutta l'opera dell'Alberti, nei suoi libri di morale dove l'etica degli stoici si mesce alle tradizioni della bontà cristiana e della
5
frugalità fiorentina, nei libri d'arte ove i precetti son confortati coll'autorità degli scritti antichi e cogli esempi delle opere loro, e nelle sue opere di architettura ove gli archi romani diventano porte, e dove la sua fedeltà ai modelli classici mal si accomoda della prossimità di altre forme che gli paiono meno perfette.
Anche quando non potè abbandonare del tutto le tradizioni paesane, come nel palazzo Rucellai, egli portò nelle forme già consacrate dal medioevo quell'ordine e quella grazia che gli venivano dai modelli classici e dagli insegnamenti di Vitruvio. Così a Rimini egli fece di tutto per seppellire la chiesetta francescana sotto il fasto della sua immaginazione ellenizzante e nel Tempio sacro alla diva Isotta egli potè, collo stesso spirito del tiranno erudito Sigismondo Malatesta, rinnegare il semplice spirito cristiano de' tempi che lo precedettero.
Egli ingentilì, cioè indebolì. Fece cose più graziose e meno solide, più regolari e meno originali. Del palazzo fiorentino a uso di fortezza, colle pietre rustiche e rozze sporgenti in fuori, colle rare finestre, egli fece l'elegante palazzo Rucellai, dai pilastri salienti gioiosamente, colle pietre levigate e ordinate, allegro all'occhio e niente terribile. Nella ferocità medievale egli innesta vagamente la leggerezza pagana.
Io ritengo l'Alberti uno dei più greci uomini che siano stati in Italia. Egli aveva il senso della misura, dell'ordine, del regolare che contraddistingue la leggenda dell'attico. Il suo amore per la geometria (si ricordino le teorie del Milhaud sul fondamento geometrico della cultura greca), la stia ricerca del tipo perfetto della bellezza umana, la sua cura delle misure, la passione dell'architettonico, del simmetrico, del non capriccioso lo accostano al tipo intellettuale dei greci.
E li rassomigliò anche per la varia curiosità, che lo fece occupare a vicenda di leggi, di lettere, di pittura, di architettura, di scultura, di fisica, di matematica, di religione, di morale e di grammatica. Egli fu il primo di quei famosi dilettanti universali del Rinascimento, che trovarono il loro eroe in Leonardo da Vinci e che lasciavano di modellare un cavallo per scrivere un apologo e si facevano ingegneri di principi dopo aver costruito una chiesa o fatte delle esperienze.
Anche in questo suo carattere l'Alberti esprime quel moto di liberazione che s'ebbe dopo che la società fortemente organica del medioevo si fu disgregata e gli uomini non si sentiron più legati alla loro città, alla loro arte, alla loro corporazione e si lanciarono, come levrieri usciti dal laccio, verso tutti i venti a inseguire tutte le prede. L'uomo chiuso, l'uomo unico, l'uomo legato ebbe fine e s'ebbe l'uomo completo, intero, universale. Il dilettantismo ebbe principio e si stimò virtuoso chi sapeva di tutto e a cui niente riusciva nuovo.
Ma se questo universalismo non fu vano finché ci furono a rappresentarlo uomini prodigiosi come l'Alberti e il Vinci, esso divenne una causa di decadimento quando i piccoli volendo di tutto occuparsi tutto guastarono e impicciolirono senza gioia.
E giova osservare che anche nell'Alberti questa universalità fu più apparente che reale, cioè più letteraria che pratica. Egli scrisse di molte cose, ma realmente ne fece poche: scrisse precetti per far pitture e sculture ma non lasciò nè quadri nè statue; dette i disegni di molte fabbriche ma, di poche diresse i lavori e se i suoi scritti son copiosi le sue azioni pratiche si ridussero ai suoi viaggi e alla carica di abbreviatore apostolico.
Egli fu dunque d'una universalità più verbale che concreta, dette insegnamenti più che opere, fu più disposto a dire ciò che si avesse a fare che ad operare di per sè. In questo carattere noi ritroviamo l'istinto aristocratico trasmesso a lui dalla ricca e potente famiglia onde usciva. Egli ci appare, nell'arte di quei tempi, il nobile che scende all'arte e non il popolano che per essa s'inalza, il signore il quale dà degli ordini ma li fa eseguire dagli inferiori e non si degna di lavorare colle sue mani come i più rozzi maestri.
Egli sente la superiorità dell'intelletto che dispone, dello spirito che immagina, vuol esser mente che forma, volontà che comanda, ma non strumento vile di esecuzione materiale. Egli portò nell'arte la bella nobiltà di sua gente; il Rinascimento estetico ebbe da lui quel suggello di aristocrazia spirituale che lo fece così mirabile e così caduco.
Avanti che il secolo s'infoscasse, e scendessero dall'Alpe i primi barbari a saccheggiare la troppo civile e troppo debole Italia, l'Alberti, nel 1472, morì serenamente a Roma. Egli aveva scritto che noi siamo creati «quasi come la nave non per marcirsi in porto, ma per solcare lunghe vie in mare e sempre tendere collo esercitarsi a qualche laude e frutto di gloria.» Ed egli poteva invero dir di sè che non s'era tenuto, come pigra galera, nelle rade.
Soltanto abbiamo l'impressione ch'egli, per la sua universalità verbale, non abbia potuto dare tutto ciò che in potenza era in lui. Ci accade dinanzi a quest'anima multiforme ed inquieta ciò che a lui accadde per la nave del lago di Nemi.
Correva un'antica tradizione che in questo lago giacesse affondata un'antica, trireme. Il cardinale Colonna incaricò l'Alberti di cercare di trarla fuori, ed egli con sottili ingegni riuscì a mandar sotto i palombari e a riportare sulla terra la prora e una parte dello scafo. Ma, dopo, l'impresa non potè continuare, o mancassero i denari o non fossero sufficienti gli ordigni, e la bella nave restò ancora per dei secoli sotto le acque.
Così l'Alberti ci ha concesse solo alcune parti della sua anima, e a noi tocca andar scandagliando per il fondo per trovare ciò ch'egli non ci ha direttamente rivelato. Ma invece di andar cercando faticosamente i dati della sua vita esteriore bisogna ricostruire in noi i fatti della sua vita interiore: in questo modo soltanto i morti ci possono esser maestri e i grandi insegnarci più alte grandezze.
◄ Indice 1904
◄ Il Regno
◄ Cronologia